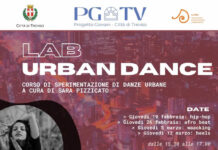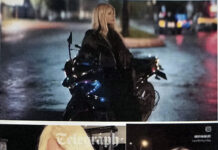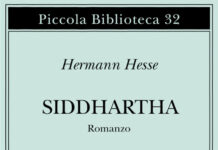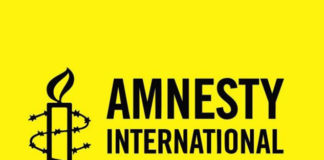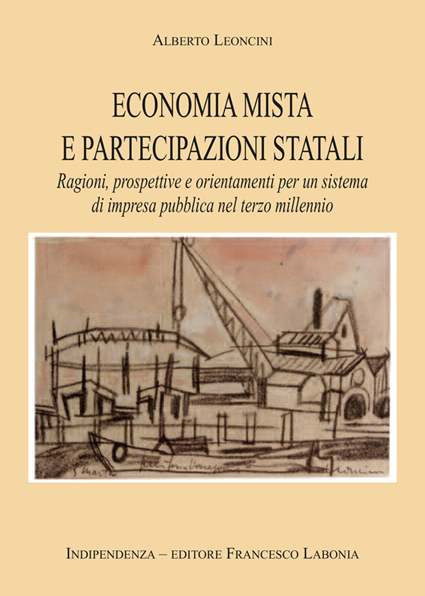
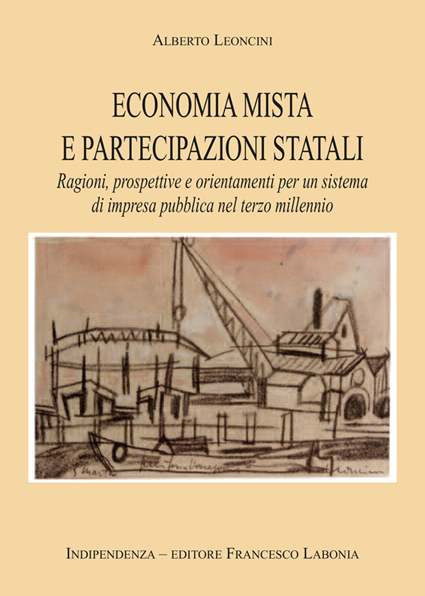
Analisi della decadenza economica italiana
Ha visto la luce il volume Economia mista e partecipazioni statali (Indipendenza-Editore Francesco Labonia), un saggio scritto dall’avvocato Alberto Leoncini che approfondisce temi economici (e, di conseguenza, politici) attuali e scottanti.
Trevigiano, classe 1988, diplomato al liceo Canova, coordinatore gruppo di lavoro endroit.it nonché studioso della vita e dell’opera di Emilio Salgari, l’avvocato Leoncini è, tra le altre cose, collaboratore della rivista romana Indipendenza, dedita a «informazione, democrazia, solidarismo, liberazione».
E proprio in linea con queste direttive, il suo saggio esamina accuratamente alcuni snodi centrali del lungo processo che, dai tempi del dopoguerra ad oggi, ha purtroppo condotto il nostro Paese non solo in uno stato di sostanziale asservimento politico-economico ad enti esterni (Unione Europea, NATO…), ma nella spirale di una inevitabile crisi economica le cui proporzioni appaiono oggi obiettivamente spaventose e difficilmente reversibili. Ma la lucida e disincantata analisi di Alberto Leoncini non esclude delle possibili alternative, per quanto ardue.
- Ciao Alberto e benvenuto sulle pagine digitali de “la Salamandra”. Come nasce e da dove viene questo libro?

Questa monografia raccoglie, sistematizza e ripropone in termini organici articoli usciti in Indipendenza frutto dello studio e dell’approfondimento personale, saldatosi in particolare con la tesi di laurea, di cui questo libro è uno sviluppo naturale. Non si tratta però della mera ristampa degli articoli, ma del tentativo di fare di questi spunti qualcosa di più strutturato.
L’intuizione di base è quella per cui tutti i movimenti di trasformazione sociale/politica post-1989 hanno eluso il tema del ruolo pubblico nell’economia: alle rivendicazioni sociali non si è mai affiancata una proposta sistemica e rivendicativa in questo senso, il tentativo è quindi di riportare nel dibattito un tema totalmente rimosso e oggetto di una liquidazione iconoclasta da parte dell’apparato mediatico e accademico, quello del ruolo dello Stato e della collettività nella sfera dei rapporti economici e di mercato. È un volume volutamente sintetico, nel senso che l’ottica è quella di fornire un testo accessibile ed efficace a chi intenda cimentarsi in attività politico-istituzionale ma, anche, in ambiti più strettamente di mercato (impresa privata, professioni etc..) per dare un contributo a iniziative di cambiamento materiale non più rinviabili nella prospettiva di contendere al blocco economico-politico dominante spazi di agibilità e avanzamenti emancipativi.
È legittimo chiedersi se abbia senso indagare un tema che, in apparenza, può apparire obsoleto e comunque “già visto”: bisogna invece essere in grado di rinnovare, nozione chiave nel mio lavoro, ciò che ci sembra immutato e codificato, un po’ come nella moda ha fatto Giorgio Armani con la “giacca destrutturata”! L’idea, insomma, è di pensare in termini radicalmente nuovi ciò che a prima vista può apparire la cosa più scontata e recidere ogni possibile equivoco sulla connivenza con la classe dirigente che, anche tramite il malgoverno delle imprese pubbliche, ci ha portato dove siamo.
- Puoi tracciare in breve, anche a chi non è addentro le discipline economiche, il panorama che offre il tuo libro? Perché un titolo come Economia mista e partecipazioni statali?
L’idea è quella di richiamare due nozioni del passato proiettandole verso il futuro. Ci tengo subito a evidenziare che non è un lavoro di storia economica né un’operazione nostalgia, anzi, non si risparmiano critiche al passato; è invece il tentativo di tracciare degli spunti propositivi attorno ai quali attivare in maniera trasversale idee, organizzazione e speranze, che è la cosa che più manca oggi, in una prospettiva di superamento critico e ri-pensamento dell’impresa pubblica.
La domanda è, quindi, cosa si può fare oggi per avviare una modifica dei rapporti di forza vigenti in campo economico? Nel testo cerco di dare degli spunti non teorici ma materiali e operativi a partire dai quali organizzare le rivendicazioni: l’avvio di meccanismi di gestione partecipativa nelle partecipate pubbliche a partire dagli enti locali e nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, la programmazione in un’ottica sistemica del lavoro nelle carceri, la riappropriazione del risparmio postale e della Cassa Depositi e Prestiti puntando a un polo bancario pubblico secondo principi etici, l’autogestione per le imprese in crisi e destinatarie di iniziative di delocalizzazione, la lotta contro il latifondo urbano e la collettivizzazione degli spazi abbandonati. Questioni molto concrete da rivendicare sul piano dell’intervento politico non in scenari futuri e ideali, ma a partire dall’oggi dando nuovo slancio a quella conquista delle “casematte” che Gramsci ci ha insegnato a rivendicare nella società. Diciamo che la prospettiva che cerco di tessere con il mio lavoro è quella di strutturare le rivendicazioni in un progetto di trasformazione complessiva della società, non già come fatti isolati ed episodici quindi intrinsecamente destinati a esaurirsi.
- Nel testo esamini molti snodi cruciali della storia economica italiana ed europea degli ultimi ottant’anni, come il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro, la dismissione dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale, fino al Trattato di Maastricht e all’immissione dell’euro come tappe irreversibili del cosiddetto processo di «integrazione europea». Da ciò emerge chiaramente l’attuale realtà dei fatti su come il nostro Paese (assieme a molti altri) sia praticamente diventato una colonia politica, economica e culturale asservito da quasi ottant’anni a Washington e Bruxelles, con un colpo micidiale inflitto proprio dalla moneta unica…
Privatizzazioni e fine del controllo sui movimenti di capitale (una delle quattro ’libertà fondamentali’ dell’ordinamento comunitario, accanto alla libera circolazione di merci, servizi e persone), la cosiddetta ’repressione finanziaria’, sono gli assi fondamentali attraverso i quali, a partire dagli anni Ottanta, il neoliberismo afferma la sua egemonia. Non una vittoria “di fase”, ma la fissazione del perimetro dell’azione politica, dello spettro delle opzioni possibili; le regole del gioco, quindi: in questo senso leggo il fallimento dei movimenti di opposizione e dissenso post- dissoluzione del blocco sovietico, cioè la rinuncia a una proposta organica in questi ambiti nella prospettiva di sfidare concretamente il potere economico.
A parlarne oggi sembra qualcosa di “estremistico” ma, fino a una manciata di anni fa, era sufficiente essere dei democristiani riformisti per dare per scontata la necessità dell’impresa pubblica, ciò dà l’idea di quanto sia sfavorevole il quadro dei rapporti di forza per chi intenda formulare una proposta alternativa.
L’integrazione monetaria è un esito del “piano inclinato” su cui siamo collocati, esiziale ma non piovuta dal cielo. L’azzeramento del mercato delle valute e dei conseguenti riallineamenti (rivalutazioni e contestuali svalutazioni) ha reso necessitata e ineludibile la compressione dei salari e il deterioramento delle condizioni materiali di vita di vastissimi strati di società, così come la contestuale necessità di scaricare i disequilibri nei conti con l’estero sul lavoro, in particolare salariato: la cosiddetta “svalutazione interna”. Possiamo dire che l’integrazione monetaria è la grande vittoria della rendita, di mercati finanziari e più in generale delle oligarchie economico-bancarie in danno delle masse lavoratrici, siano esse salariate o, per ampi tratti, anche espressione del lavoro autonomo.
L’aspetto più grave, tuttavia, è che sono temi in larga parte elusi dal dibattito e questa, politicamente, è una tragedia perché direziona tempo, energie e attenzione su questioni fondamentalmente riempitive: dai costi della politica, all’evasione fiscale (senza minimamente toccare- e non a caso!- il tema dell’elusione fiscale, compiuta attraverso strumenti perfettamente leciti tramite la stessa libera circolazione dei capitali!), ai sussidi-elemosina (come il “reddito di cittadinanza”, che evidentemente non può essere la soluzione al problema della povertà, ancorché la sua sostanziale eliminazione sia stata una toppa peggiore del buco) o, peggio, verso l’utilizzo strumentale di problemi veri in una chiave antisociale e repressiva, a partire dal tema migratorio.
- Inoltre, negli ultimi decenni si è assistito, come scrivi tu, a un «processo di privatizzazione a tappeto di tutti i settori nevralgici della vita economica italiana»… come è potuta accadere questa “spoliazione”? Gli articoli della nostra Costituzione che trattano i rapporti economici (art. 35-47) sono stati apertamente aggirati o la questione è più sottile?
La questione è anzitutto culturale: la società italiana e quelle occidentali in generale, sono state convinte che l’esperienza dell’impresa pubblica fosse un capitolo chiuso. Divenuta senso comune e patrimonio acquisito questa idea, la strada è stata in discesa: si è provveduto alle operazioni di privatizzazione nel nome del “risanamento” e dell’urgenza con meccanismi spesso opachi, eludendo frontalmente il quadro della Costituzione economica, anche e non da ultimo attraverso la natura primaziale delle fonti comunitarie, in grado di porsi in termini sovraordinati anche alla nostra Carta fondamentale, e ciò dà da pensare relativamente a quelle prospettive che pongono al loro centro la Costituzione ma, contestualmente, accettano la primazia e, più in generale, il quadro normativo-istituzionale comunitario. Si tratta di un infallibile indicatore della presa in giro nei confronti dell’elettorato, specie se accompagnato dalla costante litania sulle riforme, altro bersaglio polemico del mio libro, e sul richiamo liturgico alla Carta in termini furbeschi nel ’triduo laico’ 25 aprile-1 maggio-2 giugno.
Le privatizzazioni hanno ingenerato delle enormi rendite parassitarie alle spalle della collettività, il caso più noto sono le concessioni autostradali, ma non si dimentichino le telecomunicazioni, le linee di navigazione interna, etc… Spesso sfugge un fatto: sulle privatizzazioni c’è chi si è enormemente arricchito. E non siamo noi.
- Il tuo punto di vista è evidentemente di ispirazione marxista, ma allo stesso tempo sottolinei l’importanza centrale della questione nazionale. Che prospettive concrete vedi per una ripresa economica e una rinascita nazionale, se ne vedi? Non trovi che una premessa forse scontata, ma fondamentale e ineludibile, sarebbe quella di una rinnovata consapevolezza patriottica da parte degli Italiani, oltre ogni divisione politico-ideologica e conseguenti faziosità partitiche?
Il marxismo è, ancora oggi, una formidabile “ideologia”: utilizzo questa parola con intento volutamente polemico, nel senso che è divenuta uno spauracchio, ma essa in realtà rappresenta semplicemente le lenti con cui si guardano e interpretano i fenomeni. Non è un feticcio o un tabernacolo, è uno strumento. Posso aver bisogno di occhiali da sole o da vista per vedere meglio, ma ciò non esclude che io possa utilizzare anche un cannocchiale, un binocolo o un microscopio: sono tutti strumenti per vedere meglio, ma siamo noi a decidere cosa, se un daino nel bosco o una muffa in un vetrino. Le categorie vanno utilizzate e combinate in modo laico, senza approcci formulari o schematici.
A lato di ciò, le prospettive sono pessime: in un quarto di secolo abbiamo vissuto la bolla della “new economy” la crisi del 2008, la crisi dei debiti sovrani, la pandemia, il collasso climatico (destinato a peggiorare) e, naturalmente, l’ultima fase di guerre (militari e commerciali) e instabilità globale. Un mondo in cui una fascia ristrettissima di popolazione si arricchisce, accumula e inquina in termini che fanno impallidire l’ancien régime, non solo: alla precarietà cronicizzata come fatto strutturale ed endemico, si aggiunge oggi la concreta prospettiva di un impegno militare diretto per le nuove generazioni. Viene dunque da chiedersi se vi sia qualcosa di nuovo da aggiungere al gramsciamo: “istruitevi, agitatevi, organizzatevi!”.
Occorre fuggire ogni tentazione diciamo “deterministica”, in base alla quale sarebbero possibili esiti emancipativi all’esito del peggioramento delle condizioni materiali di vita nella società. Se le cose stessero così il socialismo si sarebbe autoaffermato da secoli: concretamente bisogna dire che è solo la saldatura fra le avanguardie intellettuali e politiche presenti nel Paese e segmenti maggioritari, ancorché plurali della società, in particolare in un contesto a capitalismo maturo, che può portare ad avanzamenti sul piano dei diritti e degli spazi di agibilità collettiva in grado di cambiare traiettoria rispetto al quadro pessimo che abbiamo di fronte, di qui, certamente, la necessità di articolare su base nazionale l’orizzonte delle rivendicazioni. Ciò che mi sento di affermare con sicurezza è che, come sempre nella storia, nulla ci verrà regalato senza che vi siano i necessari rapporti di forza per ottenerlo.
Jari Padoan