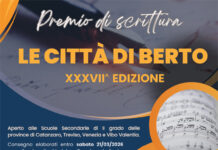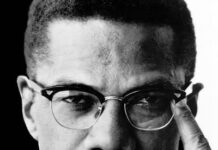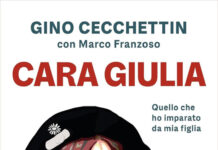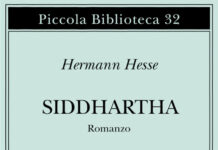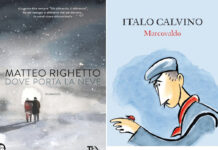Ricercatori per un giorno per una scuola sempre più Green… e Blue
Che cos’è una laguna?
Se cerchiamo il termine laguna sul dizionario Treccani troviamo: “Bacino acqueo costiero, poco profondo e con acque salate, nel quale emergono spesso formazioni insulari: si forma nelle regioni di deltazione dei grandi fiumi o negli arcipelaghi costieri con bassi fondali, ed è separato dal mare da un cordone litorale interrotto da bocche d’accesso: la laguna di Venezia o per antonomasia, la laguna”.
Insomma, la laguna di Venezia, in Italia, è la laguna per antonomasia.
Nonostante abitiamo a pochissimi chilometri di distanza, noi ragazzi del Giorgi Fermi ci siamo accorti di conoscerla veramente poco, se non qualche scorcio, attraverso il ponte della libertà, nelle gite che fin dalla primaria abbiamo fatto in direzione Venezia.
Una gita tra scienza, sostenibilità e scoperta
L’opportunità unica di una Gita Biodiversa a Venezia ci è stata data da una collaborazione tra CNR-ISMAR e la cooperativa Sestante di Venezia.
Se non li conoscete bene ve li presentiamo noi:
● L’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche svolge attività di ricerca fondamentale e applicata in oceanografia fisica, chimica e biologica e in geologia marina. L’obiettivo è contribuire allo studio dei processi oceanici e della variabilità climatica, allo sviluppo di sistemi/servizi per l’osservazione, la protezione e la gestione sostenibile dell’ambiente marino e delle coste. La sua sede principale è a Venezia, in uno dei magazzini dell’Arsenale (https://www.ismar.cnr.it/web-content/).
● La cooperativa “Sestante di Venezia”, invece è formata da un gruppo di educatori, formatori, psicologi e guide naturalistiche che dal 2000 investe competenze e professionalità, con l’intento di contribuire allo sviluppo del territorio attraverso la formazione, l’educazione, l’animazione e il turismo sostenibile (https://www.coopilsestante.com/).
In barca nella laguna di Venezia
La nostra Gita Biodiversa è partita dal piazzale di San Giobbe, dove ci ha raggiunto Filippo, educatore del Sestante, e Fabio, capitano del R.A.P.TU.S (Rispetto Ambientale Per TUrismo Sostenibile), la prima imbarcazione ibrida con motore elettrico dedicata alla navigazione in Laguna di Venezia.
Abbiamo subito appreso che la laguna di Venezia ha una superficie di 550 km², ed è collegata al mar Adriatico da 3 bocche di porto che permettono il ricambio dell’acqua: la bocca di Lido-San Nicolò, quella di Malamocco, e quella di Chioggia (vedi mappa della laguna di Venezia, fonte: https://www.mosevenezia.eu/ecosistema/).

Gli strumenti della ricerca scientifica
Accompagnati da due ricercatori del CNR, Laura e Christian, ci siamo diretti in barca verso l’Arsenale, accolti dall’installazione Building Bridge di Lorenzo Quinn, un artista che ha a cuore il cambiamento climatico.
Presso la sede del CNR, in uno dei magazzini dell’Arsenale, abbiamo preso il materiale necessario per le ricerche della giornata e ci siamo diretti verso l’isola delle Vignole, dove abbiamo condotto degli esperimenti con strumenti a noi familiari come il termometro, ed altri nuovi, come il disco di Secchi e il rifrattometro.
Come funziona il disco di Secchi?
Il disco di Secchi è uno strumento che si usa per misurare la trasparenza di un ambiente naturale, formato da spicchi bianchi e neri: si immerge legato a una fune metrata finché non si riesce più a vedere, e a quel punto si misura la profondità.
La trasparenza dell’acqua di lago, di fiume o di mare è così definita come “profondità di scomparsa del disco di Secchi”.
Il rifrattometro invece è uno strumento che misura l’indice di rifrazione di un liquido, ovvero la variazione di direzione della luce quando passa da un mezzo a un altro e permette di misurare il contenuto di sali delle acque della laguna.
I dati ambientali raccolti

L’acqua della laguna di Venezia quando l’abbiamo misurata era di 19,7 °C; la trasparenza era di 1,7 m, la salinità misurata con il rifrattometro di 35 g/l, una concentrazione intermedia tra il mare e la terra, dove si mescolano acqua dolce proveniente dai fiumi e acqua salata proveniente dal mare.
Queste misure sono importanti e eventuali loro variazioni possono essere pericolose per la flora e la fauna lagunari.
L’osservazione delle specie marine
Terminate queste prime indagini, siamo andati a osservare alcune specie marine bentoniche, cioè quelle che vivono su fondo duro come granchi, meduse, ostriche, la stella marina fragile (Ophiocomina nigra, vedi foto), cetrioli di mare (oloturie) e molti altri di cui non ricordiamo il nome.
È stato affascinante osservare un granchio blu femmina, con le uova; erano tantissime, infatti il granchio blu può deporre anche tra 2 e 8 milioni di uova per covata.
Il mondo invisibile dell’acqua
Infine con un retino con fori da 20 micrometri abbiamo fatto dei campionamenti di microfitoplancton e microzooplancton per le successive osservazioni con i microscopi e stereomicroscopi che avremo condotto nei laboratori del CNR nel pomeriggio.
Lo zooplancton è una parte del plancton marino e d’acqua dolce formato da protozoi che vivono in sospensione nelle acque e che non sono dotati di organi di locomozione, per cui si muovono di continuo per l’azione delle correnti.
L’importanza del fitoplancton
Il fitoplancton è l’insieme di organismi vegetali che vivono “sospesi” nell’acqua. Fanno parte del fitoplancton, diverse specie di alghe di dimensioni prevalentemente microscopiche.
Il fitoplancton ricopre un ruolo ecologico assolutamente fondamentale, non solo per gli ecosistemi acquatici, dei quali è alla base della catena alimentare ma anche perché svolge anche la fotosintesi clorofilliana, cioè è in grado di sintetizzare la sostanza organica e generare ossigeno sfruttando l’anidride carbonica, la luce.
Nonostante le sue piccolissime dimensioni produce oltre il 90% della sostanza organica degli oceani e circa il 50% dell’ossigeno terrestre (Fonte: arpat.toscana.it).
Ecco perché aver misurato la trasparenza dell’acqua è un’analisi importante per il buon funzionamento del microfitoplancton.
Uno stupore finale
Per terminare in bellezza la nostra giornata abbiamo osservato i piccoli esseri viventi raccolti al microscopio e ciò che abbiamo visto ci ha creato un enorme stupore.
C’è un mondo lì sotto, affollatissimo, ma a volte gli esseri umani considerano importante solo quello che vedono. Invece, come spesso capita “L’essenziale è invisibile agli occhi”.
Classe 2BMT Istituto Giorgi Fermi Treviso