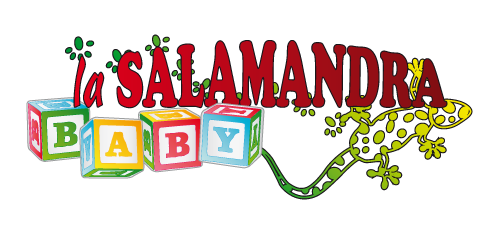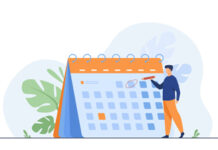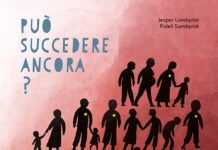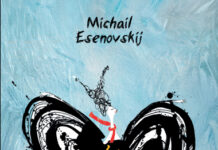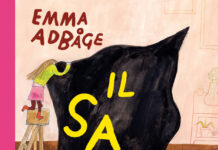Il corpo come fondamento dello sviluppo
Il corpo e le esperienze motorie strutturano e nutrono la mente, dalla gravidanza e dai primi mesi di vita in poi. Non esiste crescita senza movimento, il movimento lascia intuire la vitalità della persona (“Il movimento è vita”, diceva Aristotele). La mente registra le informazioni del corpo e, così facendo, contribuisce alla crescita del bambino. La domanda che mi pongo ora è molto semplice ed è questa: vale ancora questa riflessione, per i bambini di oggi? Come stanno i corpi dei bambini, oscillanti tra sedentarietà e multitasking estremo?
L’importanza dell’esplorazione corporea libera
Tante cose sono cambiate dai tempi di Aristotele ma la crescita delle funzioni umane segue ancora le stesse modalità di sviluppo. E quindi, che succede nelle teste (e di conseguenza nelle linee di sviluppo) dei nostri bambini, costretti a giocare in parchetti sicuramente più sicuri rispetto a qualche decennio fa, ma che, al tempo stesso, come effetto collaterale hanno quello di ridurre le possibilità di libera esplorazione corporea? In più, raccogliendo testimonianze dai genitori che chiedono una consulenza genitoriale, assisto alla progressiva riduzione degli spazi di gioco libero (“meglio che i bambini non facciano troppi schiamazzi, i vicini si lamenterebbero”), dall’altro, tutte le attività che vengono proposte ai figli sono organizzate e presidiate dagli adulti (corsi di ginnastica, sport…) con una calendarizzazione talvolta faticosa da tenere a mente, persino per gli stessi genitori. Sta venendo meno la vera possibilità di sperimentare sé stessi e il proprio corpo in assenza di uno sguardo controllante. Mi chiedo che ricadute possa avere poi, nel giro di qualche anno (con l’ingresso in adolescenza), questo atteggiamento educativo (consiglio la lettura di “Sii te stesso a modo mio”, di M. Lancini. L’autore descrive molto bene alcune ricadute educative a riguardo).
Cambiamento sociale e impatto educativo
Quello che è chiaro è che stiamo assistendo ad un cambio di prospettiva nel modo di guardare alla crescita dei bambini. Viene da pensare che questo cambio di prospettiva abbia a che fare con la velocità della quotidianità, con l’impoverimento delle relazioni interpersonali e la caduta della famiglia tradizionale, con l’emergere di un uso intensivo di smartphone e device di vario genere e tanti altri fattori. Si parla tanto di “genitori elicottero”, di genitori “spazzaneve”… entrambi accomunati dal bisogno di controllare lo sviluppo del figlio e di dirigerlo verso vie meno dolorose. “Vorrei che possa crescere serenamente, vorrei che nessuno lo maltratti né lo derida, vorrei che non conosca mai il dolore…” Evitare le emozioni negative, tenere il figlio distante da ciò che fa soffrire.
L’apprendimento emotivo e la responsabilità
Mi chiedo come possa quindi, questo bambino, una volta diventato preadolescente, imparare in solitaria ed ex novo concetti come impegno (e fatica), scelta (e rinuncia), responsabilità (e posticipazione del piacere). Concetti che, da una certa età in poi, vengono quasi “pretesi” da famiglie e scuola. Torniamo quindi ora al discorso di partenza… Se io, bambino, mi muovo esplorando e sperimentando la mia corporeità, gradualmente imparerò a conoscere i segnali del mio corpo; se imparo a gestire le sensazioni, trasformandole in emozioni alle quali so dare voce (sempre con la gradualità che contraddistingue la crescita), non mi farà paura affrontare emozioni spiacevoli. Mi sentirò competente e fiducioso. Cercherò con sicurezza e coraggio situazioni sfidanti nelle quali mettere alla prova le mie abilità emotive e più probabilmente riuscirò a costruire buone relazioni con gli altri. Non vivrò gli sbagli e gli errori come fallimenti ma come opportunità.
Il ruolo educativo degli adulti
Riesco a fare tutto questo se le mie emozioni di bambino vengono ascoltate, accolte, accettate e comprese da un genitore “buon allenatore emotivo”, che ha imparato nel tempo, a sua volta, a fare lo stesso lavoro.
Diventa quindi importante, per noi psicologi, educare gli adulti alle emozioni disturbanti o negative che provengono dall’altro, soprattutto quando questo altro è il figlio. Aiutarli a guardare a fondo, con fiducia e coraggio, nella domanda “cosa ti fa tanta paura di queste emozioni negative?”. E ripartire dal sé del singolo genitore (e poi della coppia), denso di risorse e fatiche.
Un supporto concreto al Consultorio Familiare
Al Consultorio Familiare Centro della Famiglia ci occupiamo anche di questo, attraverso il sostegno e la consulenza genitoriale. Per ogni informazione, contattare telefonicamente il Consultorio al numero 0422 oppure inviare una e-mail a segreteria@consultoriotreviso.org
Marta Benvenuti
Psicologa e psicoterapeuta del Consultorio Familiare Treviso
www.consultoriotreviso.org
www.facebook.com/ConsultorioFamiliareTreviso